“Vitti ‘na crozza” di Sara Favarò
L’autrice Sara Favarò nel saggio inerente la canzone “Vitti ‘na crozza” ha fatto un lavoro profondo e capillare di ricerca e di documentazione che le ha consentito di collocare la vicenda del testo entro precise coordinate spazio – temporali. Avvalendosi, peraltro, di preziose testimonianze ha rimesso a posto, come in un puzzle, le varie tessere, facendo emergere la verità sulla paternità di questa canzone, una delle più celebri ma meno comprese della tradizione siciliana. La canzone fu musicata, alla fine degli anni Cinquanta, da Franco Li Causi che compose la melodia su richiesta del regista Pietro Germi come brano di apertura del film dai toni lenti e cupi, “Il cammino della speranza”, tratto dal romanzo “Cuore negli abissi” dello scrittore siciliano Nino Di Maria di Sommatino. Il regista consegnò a Li Causi il testo “Vitti ‘na crozza” che gli aveva recitato un anziano minatore di Favara, Giuseppe Cibardo Bisaccia. La prima versione della canzone venne realizzata nel 1951 da Michelangelo Verso e pubblicata su settantotto giri dalla Cetra. Negli anni Settanta il canto si adattò ai toni più spensierati della ballata popolare e, allontanandosi dalla melodia originale del film, assunse un tono più allegro e folkloristico. Seppure apparentemente allegro, il testo nasconde un significato triste e intriso di ingiustizia. Si tratta di un teschio di un minatore che, attraverso il suo racconto, si fa promotore di una forte denuncia sociale soprattutto contro determinate usanze della chiesa cattolica di un tempo, relative ai minatori morti nelle zolfare. I loro resti mortali, infatti, non solo spesso rimanevano sepolti per sempre nella oscurità perenne della miniera, ma per loro erano precluse onoranze funebri e perfino, insiste il teschio nella canzone, era negato un semplice rintocco di campana. Il teschio quindi chiede pietà ed una degna sepoltura affinché nell’aldilà trovi la pace eterna. Nel saggio l’autrice, attraverso analisi dettagliate, evidenzia le varianti che la canzone, nata come testo poetico, ha subito negli anni, fornendo un vasto campionario di vari interpreti del testo con le aggiunte e le omissioni che sono state fatte rispetto all’originale. Moltissimi i cantanti che hanno interpretato la canzone talvolta nella versione integrale degli anni Cinquanta, altre volte enucleandone il corpo centrale e variandone alcune quartine iniziali o finali, altre volte le varianti sono relative ad alcuni lessemi o ad interi versi. Tra gli interpreti si ricordano Aurelio Fierro, Nilla Pizzi, Rosa Balistreri, Rosanna Fratello. il trombettista Ninni Rosso, Laura Pausini, Carmen Consoli, Vasco Rossi, Gianna Nannini ecc… Tra le rielaborazioni della canzone non si può non menzionare quella di Gabriella Ferri e Luisa De Santis che, nel 1964 hanno inciso la canzone firmando parole e musica, il cui canto si connota per un movimento lento, velocizzato leggermente alla fine della seconda e della terza strofa, oppure quella di Domenico Modugno, il cui testo è molto suggestivo e si distanzia da quello dell’incisione del 1950 nella parte introduttiva e in quellafinale. Modugno, infatti, dàsubito della canzone un’immagine scenica, quella del carrettiere che, mentre viaggia sul suo carro, si fa compagnia cantando al ritmo dello stridio delle ruote sul selciato. La bravura dell’autrice consiste nel delineare in maniera capillare Il contesto della canzone cioè la Sicilia delle zolfare che, tra Ottocento e Novecento, costituivano un altro aspetto della Sicilia che ha fatto da contraltare a quella Sicilia dalla straordinaria bellezza della natura, che avvinse Goethe nel suo viaggio in Sicilia per “ le spalliere di limoni , le palizzate di oleandri e la varietà di frutti e fragranze” ed altri letterati come Edmondo De Amicis ed Ippolito Nievo. Si tratta di una sorta di paesaggio parallelo: quello sulfureo e infernale delle zolfare in cui tra la fine dell’Ottocento e i primi del secolo scorso lavoravano figure umane macilente e allucinate svuotate dell’anima. Oltre agli adulti vi lavoravano bambini, i cosiddetti carusi che venivano privati dell’istruzione primaria e della spensieratezza dei giochi infantili. Bimbi e ragazzi, figli di famiglie indigenti, di fasce d’età comprese tra i sei e i diciotto anni, trascorrevano fino a venti ore al giorno tra i cunicoli delle miniere di zolfo, maltrattati dai picconieri e, talvolta, uccisi. Bambini e ragazzi venivano letteralmente venduti ai padroni delle miniere di zolfo poiché l’assoluta povertà delle famiglie rendeva la pratica necessaria. I contadini siciliani, sin dall’ Ottocento, affidavano i propri figli al capo picconiere con la formula di pagamento denominata “soccorso al morto” per cui i genitori del bambino ricevevano in anticipo una somma di poche lire in cambio del lavoro del bambino che, lavorando duramente, avrebbe riscattato il prestito. I “carusi” lavoravano così tra i bui e roventi cunicoli delle miniere trasportando in superficie carichi di zolfo che pesavano fino a 25 kg. per i più piccoli, e fino a 80 kg. per i ragazzi, un lavoro durissimo e condotto in modo rudimentale con il solo aiuto di pale, picconi e ceste. Non erano che pochi centesimi quelli che un caruso guadagnava giornalmente ed era dunque impossibile pensare di riscattare la somma data in prestito alla famiglia. Storpi, malandati e rachitici, i carusi siciliani sono stati protagonisti di un testo scritto nei primi anni del Novecento da un ex schiavo afro- americano, l’educatore e scrittore Booker Waschinton che così scrive a tal proposito “Da questa schiavitù non vi è alcuna speranza di libertà perché né i genitori né i figli potranno mai avere denaro sufficiente per rimborsare il prestito originari. […] I bambini sono sottoposti a crudeltà tali che nessuna crudeltà simile è mai stata segnalata nella schiavitù dei negri” Se i ragazzi avessero cercato scampo da questa schiavitù erano catturati e percossi e, talvolta anche uccisi. Nella sua opera Sara Favarò dà voce anche alle tante caruse che, nell’ambito delle miniere, erano oggetto di attenzione da parte degli adulti e che non venivano sposate perché non ritenute degne del matrimonio e, destinate ad un futuro di disprezzo, relegate ai margini della società. Sembra anche di immaginare e ascoltare, attraverso le numerose fonti fotografiche, le grida delle tante donne che correvano per strada ogni qualvolta c’era una disgrazia in miniera e temevano per la vita dei propri mariti. Il lavoro delle donne in miniera, vietato agli inizi del Novecento, arrecò danni fisici e morali alle bambine e alle donne costrette a lavorare in un ambiente malsano da ogni punto di vista. Come attestato in alcuni scritti autorevoli e rapporti medici, le ragazze avevano difficoltà ad avere figli per patologie connesse allo zolfo e, se avevano la fortuna di diventare madri, non avevano nessuna agevolazione nel salario e veniva tolto loro anche il giorno di lavoro mancato, a causa del parto. Le donne, di fatto, pur lavorando molto ricevevano un salario dimezzato rispetto a quello degli uomini. Il lavoro delle donne in miniera venne vietato dalla Legge n. 416, entrata in vigore il 25 luglio 1907 che modificava la legge n. 242 del 1902, che già vietava alle donne di lavorare in miniera e fissava il limite massimo di ore lavorative in dodici ore e, come auspicato nel 1891 nell’Enciclica Papale Rerum Novarum, prevedeva il riposo giornaliero, che veniva fissato in due ore. Per i metodi rudimentali con cui si procedeva, nelle miniere siciliane, all’estrazione dello zolfo, numerosissimi erano gli incidenti mortali o per le esalazioni eccessive del minerale, o per caduta improvvisa di massi o, ancora, per lo scoppio di lampade di acetilene come avvenne a Gessolungo a Caltanissetta, nel 1881, in cui morirono sessantacinque minatori di cui diciannove “carusi”. La fine di questa crudele pagina di storia siciliana ebbe termine quando, alla fine degli anni Settanta le zolfare vennero chiuse perché reputate antieconomiche rispetto al costo competitivo dello zolfo americano estratto con metodi più all’avanguardia. Con quest’opera Sara Favarò ha contribuito a tenere viva la memoria storica della propria terra entrando nel solco dei grandi autori che hanno raccontato la vita degli zolfatari. Il testo è corredato da fotografie sulla vita nelle zolfare in Sicilia agli inizi del Novecento dalle cui immagini, che mettono a nudo la cruda realtà del lavoro e della sofferenza dei minatori, si enuclea una triste pagina di storia regionale intrisa anche di lotte sociali. Il testo, a ben guardare è uno scrigno prezioso di notizie dal punto di vista storico-sociologico-antropologico, narrato dall’autrice con pathos e con uno sguardo indagatore, con un lessico fluido, avvolgente e coinvolgente e con un ritmo ascendente / discendente a seconda delle emozioni che la storia raccontata provoca in lei. I sintagmi inoltre, procedono con una sintassi semplice, piana, duttile e con intarsi di parole e frasi vernacolari che rendono particolarmente icastica la narrazione. In poche pagine, e con sapiente maestria Sara Favarò ha saputo affrontare problematiche scottanti della nostra Sicilia ma soprattutto ci ha raccontato il suo amore per l’Isola, terra bellissima ma segnata da profonde contraddizioni e lo ha fatto restituendo dignità letteraria ad una canzone e ad una lingua, la siciliana, affinché non se ne perda il ritmo, il colore, il suono.
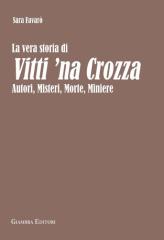
Mariza Rusignuolo


