Giallo che passione! Michele Burgio tra scrittura e vita
Dietro ogni scrittore ci sono fatiche, successi, porte chiuse, riconoscimenti, silenzi e domande aperte. Michele Burgio ce lo ha raccontato durante la rassegna letteraria “Un tè con l’autore”. La sua scrittura è una lente di ingrandimento che esplora ed interroga il mondo e l’animo umano. Il genere che più risponde a questo suo bisogno è il giallo, dove i misteri da risolvere sono un’occasione per ragionare ed aggiungere approfondimenti sulla lingua, la giustizia, la memoria, le contraddizioni di un’umanità che ci invita a specchiarci tra le pagine di narrazioni vincenti. Ecco perché bisogna andare oltre la scrittura, per provare a scoprire anche la voce, la visione e magari anche qualche fragilità dell’uomo che sta dietro alla figura dello scrittore.
Ci vuoi raccontare qualcosa di te che non si trova nelle biografie ufficiali? Un rito, un portafortuna, un evento simpatico che ci aiuta a conoscerti da un’altra prospettiva?
Visto che parliamo di un rito, io aggiungerei una sorta di coincidenza. Io lavoro di pomeriggio, perché insegno nella sezione serale dell’Istituto tecnico per il turismo ‘Marco Polo. Questo impegno professionale mi ha permesso di costruirmi una vita “a tre tempi”, direi tripartita. Il pomeriggio sono a scuola dalle 16.30 alle 20.30; la mattina la dedico alla lettura, che per me viene sempre prima della scrittura, perché in fondo la scrittura nasce dalla lettura e poi finisce per intrecciarsi con tutto il resto del mio lavoro. Il fine settimana, per quanto è possibile, lo dedico alla famiglia.
Uno dei tuoi romanzi ha un titolo che incuriosisce molto e si intitola proprio il fumo e l’incenso, che cosa rappresentano per te e perché hai scelto proprio queste due immagini?
“Il fumo e l’incenso” in realtà è una riedizione del mio secondo romanzo “Mondo è stato”. Nel 2022 era già pubblicato con un piccolo editore pescarese, Ianieri, nella collana le “Dalie Nere”. L’idea prevedeva una trilogia: il primo dei tre sul potere della Chiesa, il secondo sull’’antimafia, Il terzo sulla politica. Tre poteri istituzionali, che pur essendo buoni in potenza, spesso però sono condizionati da un potere superiore. Il primo romanzo, Mondo è stato, lo avevo mandato alla casa editrice Ianieri ed era piaciuto. Qualche tempo dopo era arrivato l’interesse del gruppo editoriale Giunti Bompiani, con il quale si è trovato un accordo per pubblicarlo con loro. Il titolo risultava criptico, i poteri della Chiesa e della mafia non erano espliciti. “Il fumo e l’incenso” invece risulta più intuitivo, perché il fumo richiama l’incenso, il sacro e contemporaneamente il fumo degli adolescenti. Il genere giallo qui è solo un pretesto, quello che mi interessa è raccontare la Sicilia e, attraverso di essa, riflettere sui destini dell’uomo.
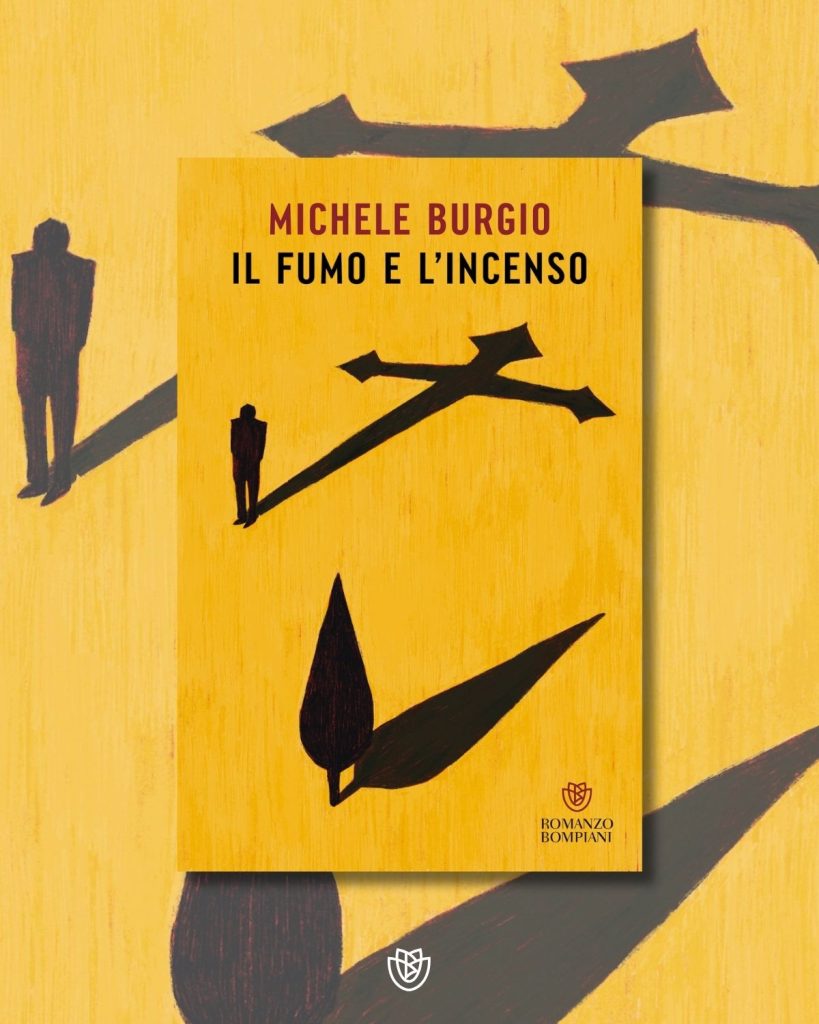
Tu parli spesso di giustizia come l’affronti? È una speranza, un’illusione o una denuncia?
La mia generazione fatica a sviluppare un pensiero ottimista nei confronti della realtà. Siamo cresciuti in un’Italia segnata dal berlusconismo, nel male più che nel bene, e in un mondo che porta ancora le ferite dell’undici Settembre. La speranza legata al tema della giustizia, che in Italia è da sempre oggetto di un dibattito di memoria sciasciana, non lascia grosse speranze. La giustizia, infatti, anche quando viene raggiunta, non sempre concreti riesce a produrre benefici per chi dovrebbe riceverli. A me interessa tutto ciò che sta attorno alla giustizia: la verità come viene fuori, come viene manipolata sino alla fine e quello che succede dopo.
Quando scrivi un giallo cosa t’interessa? Inquietare, provocare o divertire chi legge?
Il giallo, per me, è stato innanzitutto un escamotage. Non avevo appoggi, né conoscenze nel mondo della scrittura e i testi che proponevo – dal romanzo storico a quello di formazione o psicologico – non riusciva a “perciare”. Tutti quelli che leggevano i miei manoscritti mi suggerivano di sperimentare con il giallo ed alla fine avevano ragione. Di questo genere m’interessa soprattutto il ragionamento: il divertimento e la suspense sono fondamentali, ma devono trovare un equilibrio con la profondità della storia.
I tuoi personaggi sono vivi e concreti, ti sei ispirato a qualche figura reale?
Quando scriviamo di fantascienza, ognuno porta con sé un proprio idioletto, cioè un bagaglio linguistico unico ed irripetibile. Lo stesso vale per l’immaginario: ciascuno ne ha uno personale, che può smontare e rimontare a piacimento. Per questo, quando costruisco i miei personaggi, sto molto attento a non renderli mai del tutto identificabili. Sono figure che si possono modellare continuamente, cambiare, riassemblare, restando sempre in bilico tra riconoscibile e indefinito.


Puoi raccontare quella volta in cui hai detto io non mi arrendo?
Ci sono state tante volte, ma la più significativa è stato quando si è conclusa la mia esperienza universitaria, dopo 13 anni di lavoro. Pensavo che sarebbe stata la mia vita, invece si è interrotta in modo rocambolesco. In quel momento avevo due possibilità: arrendermi o andare avanti. Quando avevo iniziato in quel mondo complesso che è l’università, pensavo di non farcela: non ero figlio di persone importanti. Ho provato la stessa sensazione quando mi sono avvicinato alla scrittura. Di fronte alle grandi case editrici continuavo a dirmi “Io non ci arriverò”. Eppure, come all’università, ho trasformato quel pensiero in una sfida, in una sorta di rovello scientifico. Questa volta però con soddisfazione posso dire di avercela fatta da solo.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza nel mondo della ricerca, nonostante tu l’abbia poi abbandonata ?
Non nascondo la mia riconoscenza verso il mondo della ricerca, che ho lasciato dall’oggi al domani. Mi ha insegnato cosa significa restare seduto per giorni interi ad arrovellarmi su un problema fino a trovare una soluzione. È un metodo di lavoro che porto con me anche nella scrittura. La ricerca umanistica, in particolare, mi ha spinto a concepire ogni romanzo come un quadro già completo: la mia tesi è a monte, l’impianto c’è fin dall’inizio. Poi, certo, la scrittura si snoda passo dopo passo e solo alla fine quel quadro si rivela compiutamente.
Raccontaci qualcosa di Burgio insegnante
L’insegnamento è arrivato in modo abbastanza casuale. All’università avevo avuto qualche corso come professore a contratto, ma non mi entusiasmava: mi aspettavo dagli studenti una passione e un coinvolgimento che raramente trovavo. Contemporaneamente, per integrare gli introiti, ho insegnato nelle scuole serali, e lì è stata una vera rivelazione. Oggi insegno ai corsi serali dell’istituto linguistico Marco Polo di Palermo. Lo scorso anno avevo una classe di nove diplomande: due hanno preso il massimo dei voti all’esame di stato e altre due hanno scelto di iscriversi a Lettere moderne. È stata un’esperienza entusiasmante, un amore a prima vista, e da allora ho deciso di restare in questo mondo.
Tu fai anche divulgazione sui tuoi canali social, su Facebook dai un appuntamento ai tuoi lettori con cartoline dall’isola, vuoi parlacene?
Le cartoline dall’isola sono nate come uno strumento per farmi notare dagli editori sono brevi testi di circa 1500 battute, piccoli saggi di scrittura che prendono spunto da fotografie: a volte scattate sul momento, altri risalenti a qualche mese prima, ma sempre capaci di generare un pensiero. Per scriverle impiego molto tempo, perché hanno l’ambizione di essere equilibrate ed eleganti. So bene che un editore, prima di affidarti un contratto, legge anche i tuoi social: per questo curo personalmente l’editing e presto molta attenzione allo stile. Alla fine ne è nato un appuntamento fisso che ha raccolto un seguito affezionato di lettori. È un lavoro impegnativo ma mi diverte e mi dà grandi soddisfazioni.
Qual è il tuo rapporto con il dialetto ed in che modo stai ancora esplorando la questione della lingua?
Le competenze linguistiche maturate durante la mia esperienza di ricercatore universitario mi hanno reso molto attento all’uso della lingua. Alcuni lettori si aspettavano che, in un giallo ambientato in Sicilia, ricorressi con frequenza ai dialettismi e sono rimasti sorpresi nel non trovarli. È stata una scelta consapevole: la mia scrittura è volutamente scevra da dialettismi. In Sicilia il dialettismo letterario è ormai identificato soprattutto con la figura di Camilleri. Evitare il camillerismo è, per me, anche un atto di rispetto nei suoi confronti. Se guardo due modelli linguistici opposti come quelli di Camilleri e Sciascia, mi sento più vicino alla limpidezza ed alla purezza dello stile sciasciano. Ciò non significa che non abbia interesse per la sperimentazione linguistica: anzi, un progetto di questo tipo è nel cassetto. Ma richiede un editore coraggioso disposto a sostenerlo. Per il momento i miei gialli rappresentano un percorso per costruire un pubblico; se riusciranno a consolidarlo, allora potrò permettermi di osare di più. In caso contrario, la sperimentazione resterà sospesa.
Marisa Di Simone



