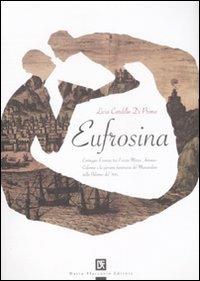Eufrosina di Licia Cardillo Di Prima
Recensione di Mariza Rusignuolo
Già il titolo del romanzo non lascia dubbi circa il personaggio su cui è incentrata l’azione.
L’asse narrativo, ruota, infatti, intorno a Eufrosina Valdaura di Siracusa, giovane baronessa di non comune bellezza, di cui parla Stendhal nelle sue “Cronache italiane” e, successivamente L. Sciascia nel romanzo “Il mare colore del vino” asserendo che questa donna, che aveva il nome di una delle tre grazie e che rappresentava la gioia, “in realtà poca gioia ebbe e diede nella sua breve vita ; e fu anzi nel destino degli altri e nel proprio una farfalla di morte”.
Licia Cardillo, ricorrendo all’espediente letterario di un manoscritto del Cinquecento, pervenutole per mano di un anonimo, sulla scia del “Don Chisciotte” di Cervantes e de “ I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, ci offre un materiale inedito preziosissimo, il carteggio tra il Viceré Marco Antonio Colonna ed Eufrosina che ricostruisce con fine tocco psicologico, la storia d’amore tra i due protagonisti sullo sfondo della storia della Palermo cinquecentesca, una storia nella storia, dunque.
Il genere dell’epistola a cui i due innamorati affidano i loro pensieri, le loro ansie e perplessità, offre all’autrice la possibilità di scandagliare l’animo e la psiche dei due personaggi e di tratteggiare la storia di un amore illecito che lascia dietro di sé una scia di morte, intrighi, ingiustizie perpetrate da un uomo, il viceré, che avrebbe dovuto ergersi a tutela della giustizia e che, invece, finiscono con l’offuscare la sua reputazione di vincitore di Lepanto.
Il racconto si snoda su due piani narrativi cui corrispondono due diversi caratteri tipografici,
il corsivo che riproduce le epistole che i due amanti si scambiano, il carattere normale che riporta la ricostruzione dell’ambiente e dei modi di vivere del tempo.
Nella storia che, gradualmente, si connota di tinte fosche, non mancano però tocchi cromatici e immagini particolarmente icastiche come nella lettera in cui il viceré scrive all’amata che la passione per lei lo fa “smaniare” alla stessa maniera in cui smania lo scirocco per la città, trascinando via tutto ciò che incontra, o la lettera in cui Eufrosina rinviene le sue fattezze nell’acqua della fontana di Porta Felice, in quelle di una statua di marmo, una sirena, e rimprovera l’amato di esporre la sua persona “ai commenti a dir poco sboccati dei palermitani”.
Per non parlare delle processioni che vengono descritte e che disegnano la mappa della città trasformandola con “finestre e balconi ornati di tappezzerie, tovaglie ricamate e lanterne, con botteghe piene di rami di alloro e di mirto”o delle informazioni sul modo di truccarsi delle donne palermitane “che spalmano sulla pelle liscia belletti, distillando in bocce gigli, uova fresche, erbe macinate e canfora”.
Particolarmente suggestiva, poi, la descrizione della città con i suoi quartieri, Porta nuova, Casa Professa, Ballarò, Bocceria, Bandiera, dove si vendono pesci, pollami, granati, erbe selvatiche e si ubicano botteghe di “cappilleri”, pelliccerie, aromatari, e dove tutta la gente viene ad “accattare”, quella Palermo che “all’alba pareva un paradiso” .
Le parti narrate dall’autrice in terza persona sono così ben integrate nel tessuto narrativo che riescono a sedurre il lettore trasportandolo nell’atmosfera del tempo e coinvolgendolo totalmente non solo per la novità del contenuti ma per la forma in cui tali contenuti sono esposti. Il ricorso a una lingua che è un’ amalgama del siciliano, dell’italiano del Cinquecento, dello spagnolo così sapientemente dosati e assemblati, rendono, infatti, ogni epistola un canto per la musicalità e il ritmo che ne scaturisce .
Ancora una volta Licia Cardillo ci ha regalato con Eufrosina una narrazione di prorompente poeticità.
Mariza Rusignuolo